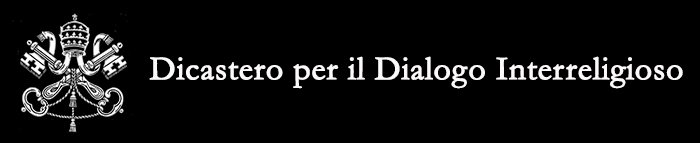Enciclica Lumen Fidei
Papa Francesco
29 guigno 2013
Estratti
Una luce illusoria?
2. Eppure, parlando di questa luce della fede, possiamo sentire l’obiezione di tanti nostri contemporanei. Nell’epoca moderna si è pensato che una tale luce potesse bastare per le società antiche, ma non servisse per i nuovi tempi, per l’uomo diventato adulto, fiero della sua ragione, desideroso di esplorare in modo nuovo il futuro. In questo senso, la fede appariva come una luce illusoria, che impediva all’uomo di coltivare l’audacia del sapere. Il giovane Nietzsche invitava la sorella Elisabeth a rischiare, percorrendo « nuove vie…, nell’incertezza del procedere autonomo ». E aggiungeva: « A questo punto si separano le vie dell’umanità: se vuoi raggiungere la pace dell’anima e la felicità, abbi pur fede, ma se vuoi essere un discepolo della verità, allora indaga ».[3] Il credere si opporrebbe al cercare. A partire da qui, Nietzsche svilupperà la sua critica al cristianesimo per aver sminuito la portata dell’esistenza umana, togliendo alla vita novità e avventura. La fede sarebbe allora come un’illusione di luce che impedisce il nostro cammino di uomini liberi verso il domani.
3. In questo processo, la fede ha finito per essere associata al buio. Si è pensato di poterla conservare, di trovare per essa uno spazio perché convivesse con la luce della ragione. Lo spazio per la fede si apriva lì dove la ragione non poteva illuminare, lì dove l’uomo non poteva più avere certezze. La fede è stata intesa allora come un salto nel vuoto che compiamo per mancanza di luce, spinti da un sentimento cieco; o come una luce soggettiva, capace forse di riscaldare il cuore, di portare una consolazione privata, ma che non può proporsi agli altri come luce oggettiva e comune per rischiarare il cammino. Poco a poco, però, si è visto che la luce della ragione autonoma non riesce a illuminare abbastanza il futuro; alla fine, esso resta nella sua oscurità e lascia l’uomo nella paura dell’ignoto. E così l’uomo ha rinunciato alla ricerca di una luce grande, di una verità grande, per accontentarsi delle piccole luci che illuminano il breve istante, ma sono incapaci di aprire la strada. Quando manca la luce, tutto diventa confuso, è impossibile distinguere il bene dal male, la strada che porta alla mèta da quella che ci fa camminare in cerchi ripetitivi, senza direzione.
13. La storia di Israele ci mostra ancora la tentazione dell’incredulità in cui il popolo più volte è caduto. L’opposto della fede appare qui come idolatria. Mentre Mosè parla con Dio sul Sinai, il popolo non sopporta il mistero del volto divino nascosto, non sopporta il tempo dell’attesa. La fede per sua natura chiede di rinunciare al possesso immediato che la visione sembra offrire, è un invito ad aprirsi verso la fonte della luce, rispettando il mistero proprio di un Volto che intende rivelarsi in modo personale e a tempo opportuno. Martin Buber citava questa definizione dell’idolatria offerta dal rabbino di Kock: vi è idolatria « quando un volto si rivolge riverente a un volto che non è un volto ».[10] Invece della fede in Dio si preferisce adorare l’idolo, il cui volto si può fissare, la cui origine è nota perché fatto da noi. Davanti all’idolo non si rischia la possibilità di una chiamata che faccia uscire dalle proprie sicurezze, perché gli idoli « hanno bocca e non parlano » (Sal 115,5). Capiamo allora che l’idolo è un pretesto per porre se stessi al centro della realtà, nell’adorazione dell’opera delle proprie mani. L’uomo, perso l’orientamento fondamentale che dà unità alla sua esistenza, si disperde nella molteplicità dei suoi desideri; negandosi ad attendere il tempo della promessa, si disintegra nei mille istanti della sua storia. Per questo l’idolatria è sempre politeismo, movimento senza meta da un signore all’altro. L’idolatria non offre un cammino, ma una molteplicità di sentieri, che non conducono a una meta certa e configurano piuttosto un labirinto. Chi non vuole affidarsi a Dio deve ascoltare le voci dei tanti idoli che gli gridano: “Affidati a me!”. La fede in quanto legata alla conversione, è l’opposto dell’idolatria; è separazione dagli idoli per tornare al Dio vivente, mediante un incontro personale. Credere significa affidarsi a un amore misericordioso che sempre accoglie e perdona, che sostiene e orienta l’esistenza, che si mostra potente nella sua capacità di raddrizzare le storture della nostra storia. La fede consiste nella disponibilità a lasciarsi trasformare sempre di nuovo dalla chiamata di Dio. Ecco il paradosso: nel continuo volgersi verso il Signore, l’uomo trova una strada stabile che lo libera dal movimento dispersivo cui lo sottomettono gli idoli.
14. Nella fede di Israele emerge anche la figura di Mosè, il mediatore. Il popolo non può vedere il volto di Dio; è Mosè a parlare con YHWH sulla montagna e a riferire a tutti il volere del Signore. Con questa presenza del mediatore, Israele ha imparato a camminare unito. L’atto di fede del singolo si inserisce in una comunità, nel “noi” comune del popolo che, nella fede, è come un solo uomo, “il mio figlio primogenito”, come Dio chiamerà l’intero Israele (cfr Es 4,22). La mediazione non diventa qui un ostacolo, ma un’apertura: nell’incontro con gli altri lo sguardo si apre verso una verità più grande di noi stessi. J. J. Rousseau si lamentava di non poter vedere Dio personalmente: « Quanti uomini tra Dio e me! »;[11] « È così semplice e naturale che Dio sia andato da Mosè per parlare a Jean-Jacques Rousseau? ».[12] A partire da una concezione individualista e limitata della conoscenza non si può capire il senso della mediazione, questa capacità di partecipare alla visione dell’altro, sapere condiviso che è il sapere proprio dell’amore. La fede è un dono gratuito di Dio che chiede l’umiltà e il coraggio di fidarsi e affidarsi, per vedere il luminoso cammino dell’incontro tra Dio e gli uomini, la storia della salvezza.
34. La luce dell’amore, propria della fede, può illuminare gli interrogativi del nostro tempo sulla verità. La verità oggi è ridotta spesso ad autenticità soggettiva del singolo, valida solo per la vita individuale. Una verità comune ci fa paura, perché la identifichiamo con l’imposizione intransigente dei totalitarismi. Se però la verità è la verità dell’amore, se è la verità che si schiude nell’incontro personale con l’Altro e con gli altri, allora resta liberata dalla chiusura nel singolo e può fare parte del bene comune. Essendo la verità di un amore, non è verità che s’imponga con la violenza, non è verità che schiaccia il singolo. Nascendo dall’amore può arrivare al cuore, al centro personale di ogni uomo. Risulta chiaro così che la fede non è intransigente, ma cresce nella convivenza che rispetta l’altro. Il credente non è arrogante; al contrario, la verità lo fa umile, sapendo che, più che possederla noi, è essa che ci abbraccia e ci possiede. Lungi dall’irrigidirci, la sicurezza della fede ci mette in cammino, e rende possibile la testimonianza e il dialogo con tutti.
D’altra parte, la luce della fede, in quanto unita alla verità dell’amore, non è aliena al mondo materiale, perché l’amore si vive sempre in corpo e anima; la luce della fede è luce incarnata, che procede dalla vita luminosa di Gesù. Essa illumina anche la materia, confida nel suo ordine, conosce che in essa si apre un cammino di armonia e di comprensione sempre più ampio. Lo sguardo della scienza riceve così un beneficio dalla fede: questa invita lo scienziato a rimanere aperto alla realtà, in tutta la sua ricchezza inesauribile. La fede risveglia il senso critico, in quanto impedisce alla ricerca di essere soddisfatta nelle sue formule e la aiuta a capire che la natura è sempre più grande. Invitando alla meraviglia davanti al mistero del creato, la fede allarga gli orizzonti della ragione per illuminare meglio il mondo che si schiude agli studi della scienza.
La fede e la ricerca di Dio
35. La luce della fede in Gesù illumina anche il cammino di tutti coloro che cercano Dio, e offre il contributo proprio del cristianesimo nel dialogo con i seguaci delle diverse religioni. La Lettera agli Ebrei ci parla della testimonianza dei giusti che, prima dell’Alleanza con Abramo, già cercavano Dio con fede. Di Enoc si dice che « fu dichiarato persona gradita a Dio » (Eb 11,5), cosa impossibile senza la fede, perché chi « si avvicina a Dio, deve credere che egli esiste e che ricompensa coloro che lo cercano » (Eb 11,6). Possiamo così capire che il cammino dell’uomo religioso passa per la confessione di un Dio che si prende cura di lui e che non è impossibile trovare. Quale altra ricompensa potrebbe offrire Dio a coloro che lo cercano, se non lasciarsi incontrare? Prima ancora, troviamo la figura di Abele, di cui pure si loda la fede a causa della quale Dio ha gradito i suoi doni, l’offerta dei primogeniti dei suoi greggi (cfr Eb 11,4). L’uomo religioso cerca di riconoscere i segni di Dio nelle esperienze quotidiane della sua vita, nel ciclo delle stagioni, nella fecondità della terra e in tutto il movimento del cosmo. Dio è luminoso, e può essere trovato anche da coloro che lo cercano con cuore sincero.
Immagine di questa ricerca sono i Magi, guidati dalla stella fino a Betlemme (cfr Mt 2,1-12). Per loro la luce di Dio si è mostrata come cammino, come stella che guida lungo una strada di scoperte. La stella parla così della pazienza di Dio con i nostri occhi, che devono abituarsi al suo splendore. L’uomo religioso è in cammino e deve essere pronto a lasciarsi guidare, a uscire da sé per trovare il Dio che sorprende sempre. Questo rispetto di Dio per gli occhi dell’uomo ci mostra che, quando l’uomo si avvicina a Lui, la luce umana non si dissolve nell’immensità luminosa di Dio, come se fosse una stella inghiottita dall’alba, ma diventa più brillante quanto è più prossima al fuoco originario, come lo specchio che riflette lo splendore. La confessione cristiana di Gesù, unico salvatore, afferma che tutta la luce di Dio si è concentrata in Lui, nella sua “vita luminosa”, in cui si svela l’origine e la consumazione della storia.[31] Non c’è nessuna esperienza umana, nessun itinerario dell’uomo verso Dio, che non possa essere accolto, illuminato e purificato da questa luce. Quanto più il cristiano s’immerge nel cerchio aperto dalla luce di Cristo, tanto più è capace di capire e di accompagnare la strada di ogni uomo verso Dio.
Poiché la fede si configura come via, essa riguarda anche la vita degli uomini che, pur non credendo, desiderano credere e non cessano di cercare. Nella misura in cui si aprono all’amore con cuore sincero e si mettono in cammino con quella luce che riescono a cogliere, già vivono, senza saperlo, nella strada verso la fede. Essi cercano di agire come se Dio esistesse, a volte perché riconoscono la sua importanza per trovare orientamenti saldi nella vita comune, oppure perché sperimentano il desiderio di luce in mezzo al buio, ma anche perché, nel percepire quanto è grande e bella la vita, intuiscono che la presenza di Dio la renderebbe ancora più grande. Racconta sant’Ireneo di Lione che Abramo, prima di ascoltare la voce di Dio, già lo cercava « nell’ardente desiderio del suo cuore », e « percorreva tutto il mondo, domandandosi dove fosse Dio », finché « Dio ebbe pietà di colui che, solo, lo cercava nel silenzio ».[32] Chi si mette in cammino per praticare il bene si avvicina già a Dio, è già sorretto dal suo aiuto, perché è proprio della dinamica della luce divina illuminare i nostri occhi quando camminiamo verso la pienezza dell’amore.
La fede e il bene comune
50. Nel presentare la storia dei Patriarchi e dei giusti dell’Antico Testamento, la Lettera agli Ebrei pone in rilievo un aspetto essenziale della loro fede. Essa non si configura solo come un cammino, ma anche come l’edificazione, la preparazione di un luogo nel quale l’uomo possa abitare insieme con gli altri. Il primo costruttore è Noè che, nell’arca, riesce a salvare la sua famiglia (cfr Eb 11,7). Appare poi Abramo, di cui si dice che, per fede, abitava in tende, aspettando la città dalle salde fondamenta (cfr Eb 11,9-10). Sorge, dunque, in rapporto alla fede, una nuova affidabilità, una nuova solidità, che solo Dio può donare. Se l’uomo di fede poggia sul Dio-Amen, sul Dio fedele (cfr Is 65,16), e così diventa egli stesso saldo, possiamo aggiungere che la saldezza della fede si riferisce anche alla città che Dio sta preparando per l’uomo. La fede rivela quanto possono essere saldi i vincoli tra gli uomini, quando Dio si rende presente in mezzo ad essi. Non evoca soltanto una solidità interiore, una convinzione stabile del credente; la fede illumina anche i rapporti tra gli uomini, perché nasce dall’amore e segue la dinamica dell’amore di Dio. Il Dio affidabile dona agli uomini una città affidabile.
51. Proprio grazie alla sua connessione con l’amore (cfr Gal 5,6), la luce della fede si pone al servizio concreto della giustizia, del diritto e della pace. La fede nasce dall’incontro con l’amore originario di Dio in cui appare il senso e la bontà della nostra vita; questa viene illuminata nella misura in cui entra nel dinamismo aperto da quest’amore, in quanto diventa cioè cammino e pratica verso la pienezza dell’amore. La luce della fede è in grado di valorizzare la ricchezza delle relazioni umane, la loro capacità di mantenersi, di essere affidabili, di arricchire la vita comune. La fede non allontana dal mondo e non risulta estranea all’impegno concreto dei nostri contemporanei. Senza un amore affidabile nulla potrebbe tenere veramente uniti gli uomini. L’unità tra loro sarebbe concepibile solo come fondata sull’utilità, sulla composizione degli interessi, sulla paura, ma non sulla bontà di vivere insieme, non sulla gioia che la semplice presenza dell’altro può suscitare. La fede fa comprendere l’architettura dei rapporti umani, perché ne coglie il fondamento ultimo e il destino definitivo in Dio, nel suo amore, e così illumina l’arte dell’edificazione, diventando un servizio al bene comune. Sì, la fede è un bene per tutti, è un bene comune, la sua luce non illumina solo l’interno della Chiesa, né serve unicamente a costruire una città eterna nell’aldilà; essa ci aiuta a edificare le nostre società, in modo che camminino verso un futuro di speranza. La Lettera agli Ebrei offre un esempio al riguardo quando, tra gli uomini di fede, nomina Samuele e Davide, ai quali la fede permise di « esercitare la giustizia » (Eb 11,33). L’espressione si riferisce qui alla loro giustizia nel governare, a quella saggezza che porta la pace al popolo (cfr 1 Sam 12,3-5; 2 Sam 8,15). Le mani della fede si alzano verso il cielo, ma lo fanno mentre edificano, nella carità, una città costruita su rapporti in cui l’amore di Dio è il fondamento.