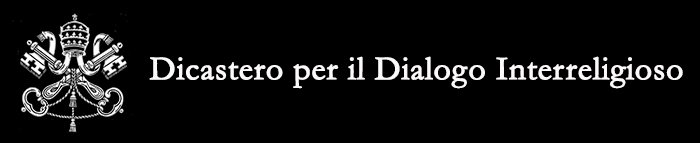CENNI STORICI SUL DICASTERO
PER IL DIALOGO INTERRELIGIOSO
Da sempre, il dialogo interreligioso, esemplificato da santi come Francesco d’Assisi, ha fatto parte dell’approccio cristiano, ma negli anni ’60 è entrato in una nuova epoca. Con i profondi cambiamenti portati dal Concilio Vaticano II, si inaugura infatti una nuova via ufficiale di dialogo tra la Chiesa e i seguaci delle altre religioni.
Nel 1964, il papa San Paolo VI istituì il Segretariato per i non Cristiani, che divenne poi il Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso, e poi il Dicastero per il Dialogo Interreligioso, che come tale, negli anni seguenti, ha servito la Chiesa e la sua missione di dialogo. In particolare, i Pontefici hanno offerto guida e orientamenti per le iniziative del Dicastero.
1964-1978
Sotto il Pontificato di Papa Paolo VI
È noto che Papa Paolo VI ha condotto la Chiesa a una nuova consapevolezza dell’importanza del dialogo, sia all’interno che all’esterno della Chiesa. Nel 1964, nel bel mezzo del Concilio Vaticano II, egli istituì il Segretariato per i non-Cristiani, poi conosciuto come Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso (PCDI). Nel decreto istitutivo, il Papa dichiarava: “L’ardore della divina carità deve ispirare la Chiesa, che continua l’opera di Cristo, specialmente in questi giorni nei quali si sviluppano molte relazioni tra uomini di ogni razza, lingua e religione. Perciò, per nostra iniziativa… in virtù di questa lettera erigiamo e costituiamo uno speciale Consiglio o Segretariato per i non-Cristiani…”.
L’enciclica del 1964 di Papa Paolo VI Ecclesiam Suam (La Sua Chiesa) detta il tono del suo pontificato, focalizzandolo sull’apertura e il dialogo. Scrive il Papa: “Per tali motivi, Ci proporremo, in questa Enciclica, di sempre più chiarire a tutti quanto, da una parte, sia importante per la salvezza dell’umana società, e dall’altra quanto stia a cuore alla Chiesa che ambedue s’incontrino, si conoscano, si amino” (3).
Nei primi anni, l’operato del Segretariato per i non Cristiani prese le mosse dalla sua sede a Roma, grazie all’entusiasmo di esperti delle altre religioni, vissuti in contesti culturali diversi, che avevano messo in pratica i principi del dialogo. Tra costoro si devono citare il Cardinale Paolo Marella, primo Presidente, Mons. Piero Rossano, poi vescovo ausiliare di Roma, e Monsignor Marcello Zago, membro degli Oblati di Maria Immacolata. Essi invitarono esperti a redigere linee guida per il dialogo con i buddisti, gli induisti, i musulmani e i seguaci della religione tradizionale africana. Collaborarono con i vescovi, le organizzazioni episcopali, e i membri della Chiesa attivi nel dialogo nel mondo. Così ebbero inizio incontri ufficiali di dialogo tra il Segretariato e vari gruppi religiosi.
In questo tempo, a sviluppare attività di dialogo in ogni parte del mondo in modo mai visto prima, non fu solo il Segretariato per i non Cristiani, ma l’intera Chiesa cattolica, seguendo le direttive del Concilio Vaticano II. Fu un momento emozionante e talora caotico nella Chiesa, un tempo di esperimento e chiarificazione, per porre le fondamenta e definire i ruoli.
1978-2005
Sotto il Pontificato di Giovanni Paolo II
Papa Giovanni Paolo II infuse slancio ed entusiasmo nel lavoro per il dialogo interreligioso. Come disse uno studioso, “Da buon filosofo, Giovanni Paolo II vide lo Spirito di Dio all’opera in altre religioni (Redemptor hominis 6). Da viaggiatore esperto, accostò molti politici di altre fedi e diede ispirazione a milioni di giovani non cristiani. Da guida carismatica, riuscì ad invitare le religioni del mondo a pregare insieme ad Assisi per la pace” (Felix Korner, S.J.).
L’evento di più alto profilo in cui fu coinvolto in questo tempo il Segretariato per i non Cristiani fu l’incontro di preghiera per la Pace ad Assisi nel 1986. Nella città di san Francesco l’incontro di preghiera attirò 50 rappresentanti di comunità cristiane e 60 di altre religioni. Papa Giovanni Paolo II credeva fortemente nel potere della preghiera di cambiare i cuori e le situazioni del mondo. All’incontro di preghiera, disse: “Anche se ci sono molte e importanti differenze tra noi, c’è anche un fondo comune, donde operare insieme nella soluzione di questa drammatica sfida della nostra epoca: vera pace o guerra catastrofica? Sì, c’è la dimensione della preghiera, che pur nella reale diversità delle religioni, cerca di esprimere una comunicazione con un Potere che è al di sopra di tutte le nostre forze umane. La pace dipende fondamentalmente da questo Potere che chiamiamo Dio, e che, come noi cristiani crediamo, ha rivelato sé stesso in Cristo”.
Il Segretariato, rinominato nel 1988 Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso (PCDI), continuò ad ampliare le relazioni con i partner del dialogo, stabilendo il dialogo ufficiale con musulmani, buddisti, indù e sikh, allo scopo di favorire la mutua comprensione e collaborazione su temi importanti per l’umanità, come i diritti umani, la pace, e il dialogo interreligioso.
Accanto ai messaggi augurali indirizzati ai musulmani per il Ramadan a partire dal 1967, il PCDI iniziò nel 1995 ad inviare saluti ai buddisti per la festa di Vesakh; nel 1996 anche gli indù cominciarono a ricevere saluti per la festa di Diwali. Questi messaggi diventarono un mezzo importante per esprimere l’amicizia e restare in contatto con i seguaci delle altre religioni.
Nel documento “Dialogo e Missione”, pubblicato nel 1984, trovarono espressione gli sforzi iniziali del Segretariato per chiarire il significato dell’opera del dialogo per sé e per la Chiesa. Frutto di ampia discussione ed esperienza, il documento spiegava che il dialogo “è un mezzo per agire, un atteggiamento e uno spirito che guida il comportamento personale. Esso comporta attenzione, rispetto, e ospitalità per l’altro, lasciando spazio all’identità dell’altro, ai suoi modi di espressione, e ai suoi valori”. Al contempo, un cristiano impegnato nel dialogo proclama pure il Vangelo di Gesù Cristo in parole ed azioni. Dialogo e missione, non sono in contraddizione, ma vanno di pari passo. La riflessione della Chiesa su questa verità è un compito permanente, al quale il PCDI dedica una costante attenzione.
Nel 1991, il PCDI ha sviluppato ulteriormente questo tema, con la pubblicazione del documento Dialogo e annuncio, frutto della collaborazione tra il PCDI e il Dicastero per l’Evangelizzazione dei Popoli, nel quale trova spiegazione una questione d’interesse crescente con l’evoluzione della pratica del dialogo: per un cristiano, quale rapporto c’è tra il dialogo e l’annuncio del Vangelo di Gesù Cristo? In questo testo esauriente viene affrontato in modo diretto il tema dei doni e delle sfide della proclamazione del Vangelo in un mondo pluralistico. I cristiani sono chiamati a proclamare il Cristo alla maniera di Cristo – con rispetto, apertura, obbedienza alla verità, e pazienza – cioè, in modo dialogico.
2005-2013
Sotto il Pontificato di Papa Benedetto XVI
Stando ad alcuni studiosi del dialogo Interreligioso, il modo peculiare di Benedetto XVI nel condurre il dialogo interreligioso era “riflettere con gli altri” (Korner) con “una distintiva enfasi sulla verità” (Howard). Scrive il Pontefice nell’enciclica Caritas in veritate: “La ragione ha sempre bisogno di essere purificata dalla fede … A sua volta, la religione ha sempre bisogno di venire purificata dalla ragione per mostrare il suo autentico volto umano. La rottura di questo dialogo comporta un costo molto gravoso per lo sviluppo dell’umanità” (56).
Come il suo predecessore, nei suoi viaggi apostolici, Papa Benedetto era ansioso di partecipare agli incontri interreligiosi. Nel 2011, in occasione del 25° anniversario del primo Incontro di Preghiera di Assisi, ne convocò un secondo incontro, al quale parteciparono circa 180 rappresentanti di varie religioni.
Fu in questo periodo che crebbe l’attenzione verso le religioni dell’Asia, con i viaggi in India, Giappone, Corea e Indonesia, avviando dialoghi strutturati con organizzazioni indù, buddiste, sikh e giainiste e l’invio, per la prima volta, di messaggi ai giainisti e ai sikh in occasione delle loro rispettive feste.
In linea con Caritas in veritate, il PCDI pubblicò, nel 2014, Dialogo nella Carità e nella Verità. Benché pubblicato dopo le dimissioni di Papa Benedetto, questo documento era stato già redatto dopo l’Assemblea plenaria del PCDI. Si tratta della terza più importante pubblicazione, che sintetizza i precedenti insegnamenti sul dialogo interreligioso e ne applica i principi alla situazione attuale, in considerazione dei mutati contesti culturali, con la globalizzazione, la crescente strumentalizzazione della religione per giustificare azioni violente, e la proliferazione di attività di dialogo relativistiche, che non sempre rispettano le profonde differenze tra le tradizioni religiose.
2013-
Sotto il Pontificato di Papa Francesco
Nel 2014, ancora all’inizio del pontificato di Papa Francesco, Fr. Damian Howard, SJ, esperto di dialogo interreligioso, scrisse: “Con Papa Francesco la Chiesa sta acquistando consapevolezza della sua natura missionaria. Analogamente, è probabile che crescerà nell’apprezzare il ruolo del dialogo al servizio di quella missione”.
In effetti, dal 2013 il dialogo, e in particolare il dialogo interreligioso, è stato al centro del palcoscenico negli insegnamenti del Santo Padre sulla natura missionaria ed evangelizzatrice della Chiesa. Papa Francesco ha messo in luce la necessità di sviluppare l’amicizia con i seguaci delle altre religioni. Frutto di una di queste sue amicizie è stata, nel 2019, la firma del Documento sulla Fratellanza Umana con Ahmed Al-Tayyib, grand-imam di Al-Azhar. Questo documento invita cristiani, musulmani, e tutte le persone di buona volontà, a costruire un mondo di fraternità umana: “Il dialogo, la comprensione, la diffusione della cultura della tolleranza, dell’accettazione dell’altro e della convivenza tra gli esseri umani contribuirebbero notevolmente a ridurre molti problemi economici, sociali, politici e ambientali che assediano grande parte del genere umano”.
Nell’enciclica Fratelli Tutti, Papa Francesco sottolinea l’unicità e la bontà della fede cristiana e presenta una visione della possibile collaborazione tra popoli e religioni diversi in vista della pace e giustizia nel mondo.
Papa Francesco si è impegnato a visitare molti paesi multireligiosi e ha incoraggiato le popolazioni cristiane, e in particolare i responsabili religiosi e politici a sostenere il progresso dei diritti umani e civili per tutti.
Il PCDI continua il suo lavoro, coltivando vecchie e nuove relazioni di dialogo con simposi, pubblicazioni e lo scambio di visite. Nel 2016 ha avuto inizio il dialogo con i taoisti. Per restare in contatto con i partner del dialogo, durante la pandemia, il PCDI ha fatto buon uso dei webinar.
Rivolgendosi al G20 Interfaith Forum nel mese di ottobre 2020, l’attuale presidente del PCDI, il Cardinal Miguel Ángel Ayuso Guixot, ha espresso così la sfida e il dono del dialogo interreligioso: “Il mondo sta attraversando un momento molto buio, che richiede risposte e soluzioni adeguate per i problemi della nostra esistenza. La famiglia umana ha davvero bisogno di ritrovarsi con uno spirito unificato e una reale amicizia per offrire soluzioni ai nostri comuni problemi”.